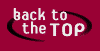INTERVIEW:
Domanda 1
Che cosa sono le tecno-utopie?
Risposta
Credo si possa dire che fin dagli inizi, le tecniche di comunicazione - di qualunque
genere fossero, quelle fisiche come i mezzi di trasporto, oppure immateriali, relative
cioè al trasporto dei segni, - siano sempre state accompagnate da discorsi di carattere
utopico. Parlo di utopia nel senso che, in fondo, è presente l'idea di una redenzione ad
opera della comunicazione, e il dato più interessante è che ciò ha attraversato tutte
le generazioni della tecnica, a cominciare dai grandi viaggi. Basterebbe, per esempio,
rileggere i testi di Marco Polo sulla Cina e osservare come il modello cinese abbia
percorso tutto il Rinascimento, specialmente in Francia. Come mai la comunicazione è
stata profondamente segnata da questa tecno-utopia? Perché dietro il concetto di
comunicazione c'è l'idea di una liberazione degli scambi. Se consideriamo che
l'Illuminismo, ad esempio, era fondato sull'idea di scambio come momento di creazione di
valori, ecco che a livello tecnico la prima vera utopia apparve già con il telegrafo
ottico, perciò alla fine diciottesimo secolo, ai tempi della rivoluzione francese. E già
a quell'epoca si fanno avanti dei rivoluzionari i quali reputano che basterebbe
predisporre diramazioni fra i cittadini e moltiplicare le linee attraverso tutto il
territorio perché la gente dia vita a ciò che in quel momento viene definito come una
grande repubblica democratica. Così in effetti essi smentivano le tesi e le affermazioni
di Jean Jacques Rousseau, secondo il quale non poteva esistere democrazia e Agorà se non
a portata di voce. Ecco invece che con il telegrafo ottico questo diventava possibile per
mezzo di una rete: i rivoluzionari dell'89 già ci avevano pensato ed erano convinti di
disporre degli strumenti necessari per costituire, finalmente, una democrazia partendo
dalla rete telegrafica, che a quei tempi in effetti funzionava ancora in modo
sostanzialmente manuale.

Domanda 2
A proposito di "globalizzazione", ce ne può dare una definizione?
Risposta
Possiamo rapportarci a questo fenomeno sotto un duplice aspetto. In primo luogo la
globalizzazione corrisponde a una realtà concreta, e che ad esempio consista soprattutto
nell'accerchiamento del pianeta ad opera di reti finanziarie. E del resto il termine
"globalizzazione" in pratica è nato con la deregolamentazione finanziaria degli
anni 1980-85. Ci sono perciò dei dati di fatto, vale a dire che i territori degli
stati-nazione sono sempre più indotti a collegarsi con la dimensione mondiale. Il secondo
aspetto che vorrei ricordare è che la globalizzazione è anche una ideologia, nel senso
che in definitiva attraverso la globalizzazione si ottiene un modello di riordinamento del
mondo. È ciò che gli americani, gli esperti americani di geopolitica e gli strateghi del
Pentagono, chiamano World Shaping, che significa in sostanza il rimodellamento del mondo a
partire dall'idea della globalità. Dietro il concetto di globalizzazione c'è pertanto
anche un particolare progetto di ristrutturazione mondiale in funzione di certi interessi
e di certe società. Soprattutto oggi non si può analizzare il processo di
globalizzazione attualmente in corso prescindendo dal nuovo ruolo svolto dalla strategia
egemonica degli Stati Uniti. La globalizzazione si sposa e fa rima con la nozione di
unipolarismo, e credo che questo sia un aspetto fondamentale.

Domanda 3
Invece che cosa vuol dire "mondializzazione"?
Risposta
Questo è molto interessante. In effetti, per l'appunto, non ci si interroga sulla
differenza fra globalizzazione e mondializzazione. Perché non lo si fa? Proprio perché,
parallelamente alla deregolamentazione dei sistemi di comunicazione, che si tratti delle
reti telefoniche o audiovisive, c'è stata anche un'altra deregolamentazione: quella degli
universi concettuali che vengono impiegati per definire il mondo. Ed è vero che nessuno
si chiede chi formula queste nozioni. Ad esempio, "globalizzazione" è un
termine che viene dall'ambito finanziario, e da lì si è esteso alla cultura, ai media.
Perciò il grave problema che si presenta oggi è il fatto che siamo obbligati a usare
parole di cui non conosciamo l'origine, e che in genere sono desunte da determinati ambiti
e in definitiva sono anche veicoli di una concezione liberoscambista del mondo, fondata
sul libero scambio, e muovono dunque in quella direzione. E allora, il concetto di
mondializzazione è un concetto che resta geografico, nel senso che in sostanza indica le
strategie geografiche di diversi soggetti a vocazione mondiale. E' un concetto intermedio,
a differenza della globalizzazione che rappresenta un concetto proprio della cibernetica,
e che in definitiva consiste nella concezione del mondo come sistema, e rimanda a una
gestione del mondo come sistema informatico: è pertanto un'ideologia. Il termine
"mondializzazione" ha una storia molto più antica: come lei sa questa parola,
nella forma "mondialismo", in inglese "Worldism", esiste fin dagli
inizi di questo secolo, e la ritroviamo ad esempio nelle rivendicazioni presenti nei vari
progetti che hanno dato origine alla Società delle Nazioni e alla Lega delle Nazioni.
L'idea di mondializzazione ha insomma una memoria storica, mentre quella di
globalizzazione ne è priva, e parte appunto da un processo di globalizzazione
finanziaria, ossia di una interconnessione a livello mondiale. Questo è in realtà
l'unico settore veramente globalizzato: quello della finanza, delle reti finanziarie che
comunicano in tempo reale. E come dicevo, è un concetto nato in una dimensione di utopia
sociale.

Domanda 4
Cosa vuol dire oggi comunicare in presenza di una simile pluralità di codici e di
linguaggi diversi?
Risposta
Oggi ci troviamo di fronte a una panoplia di media, ciascuno con un suo proprio universo.
E' vero che i vari sistemi di comunicazione usano linguaggi differenti e si rivolgono a
destinatari diversi, e si potrebbe affermare che esistono particolari culture mediatiche,
le quali del resto spesso rinviano a sistemi culturali molto più ampi e complessi.
Proprio qui sta il grande problema del mondo contemporaneo, certamente uno dei problemi
maggiori: fino a oggi avevamo un insieme di media, dal giornale alla radio alla
televisione, la cui vocazione naturale era perfettamente espressa da un bellissimo termine
in voga nell'Ottocento in riferimento a tutte le reti di comunicazione -- la
comunicazione, si diceva, deve "legare", dal latino "religare", ossia
doveva avere la stessa funzione della religione. Ebbene, oggi il problema è che
l'esplosione delle diverse tecnologie fa sì che la funzione di legame sociale, per così
dire, a livello di un territorio ben determinato, venga messa in crisi dall'esistenza di
tecnologie di comunicazione molto più orientate verso un'idea di eterogeneità e di
rispetto delle diversità. Qui sta il vero problema. C'è anche chi sostiene che, in fin
dei conti, i veri media di oggi sono Internet e la televisione. Per quanto mi riguarda,
sono assolutamente convinto che questa sia una visione apocalittica, e credo che in ogni
periodo storico ciascun medium, ciascun vettore si trovi a ridefinire il proprio ruolo in
rapporto agli altri.

Domanda 5
Ora vorrei rivolgerle una domanda a proposito del Millennium Bug: cosa crede che
succederà?
Risposta
Questa è una questione che mi interessa poco, perché è diventata un vero e proprio mito
e fa parte di un atteggiamento millenaristico nei confronti del prossimo millennio. Credo
che senza dubbio esista un problema reale sotto il profilo tecnico, se vuole, ma al di là
di questo si torna un po' alle tecno-utopie e il problema è proprio che anche questo vi
contribuisce, e si inserisce in un nuovo tipo di proiezioni immaginarie che accompagnano
le tecnologie.

Domanda 6
In che modo cambiano i rapporti interpersonali quando si usa un medium come Internet? Ci
sono persone che si conoscono, dialogano, si innamorano, eppure non si sono mai viste.
Dunque si pone anche un problema di identità nella dimensione di Internet. Come si
trasformano allora le relazioni fra gli individui?
Risposta
In rapporto al problema delle persone che non si sono mai incontrate e che alla fine
possono effettivamente innamorarsi l'una dell'altra attraverso la Rete, dobbiamo ammettere
che ancora non si conoscono abbastanza gli effetti di Internet, e che soltanto ora si
comincia a studiarne non soltanto le conseguenze, ma anche le modalità di impiego. Ad
ogni modo, quel che si può certamente affermare, quel che è evidente, riguarda l'ambito
politico: Internet introduce nuovi modi di fare politica. Non arriverò a dire, come
pretendono i libertari statunitensi, che finalmente è nato un nuovo partito, o che presto
nasceranno nuovi partiti, i partiti virtuali. Quel che io vedo concretamente è che alcuni
tipi di azione politica sono divenuti possibili mentre prima non lo erano. Traggo un
esempio dal processo di regolamentazione dell'intero scenario della comunicazione: è
sorta un'opposizione da parte di oltre seicento ONG, organizzazioni non governative di
circa seicento paesi, contro l'accordo multilaterale sugli investimenti Come sa, si tratta
di una famosa convenzione che in definitiva si prefiggeva di deregolamentare completamente
la circolazione dei capitali, e che perciò si ripercuoteva direttamente sulle regole
esistenti in materia di audiovisivi, ad esempio, in Europa. Ebbene, è interessante
osservare per l'appunto come attraverso Internet, collegandosi alla rete, si sia
realizzata una mobilitazione mondiale contro una certa iniziativa politica. Perciò la mia
riflessione è piuttosto di natura politica. In effetti si pongono anche altri problemi a
livello di relazioni individuali, ma qui siamo ancora nel campo della pura speculazione.

Domanda 7
Qualcuno sostiene che grazie a Internet avremo più democrazia, e che per mezzo delle reti
informatiche in futuro sarà possibile controllare l'opera dei politici e i cittadini
potranno esprimere più efficacemente e frequentemente la propria opinione.
Risposta
Qui torniamo alla tecno-utopia dei rivoluzionari del 1789. C'è comunque un dato
elementare su cui tutti sono d'accordo, eccetto Bill Gates. Ad esempio, oggi siamo in
presenza di una crescente biforcazione fra ricchi e poveri, e che appena il 2% della
popolazione mondiale è collegata a Internet. Cominciamo allora a discutere di questo.
Secondo il principio democratico tutti dovrebbero disporre delle stesse possibilità di
accesso alle nuove tecnologie.

Domanda 8
Quindi, visto che in definitiva moltissime persone non sono collegate a Internet, si può
parlare del problema della disparità di accesso alle nuove tecnologie tra poveri e
ricchi, tra nord e sud del mondo?
Risposta
Questo è un problema fondamentale, centrale per l'evoluzione delle nuove tecnologie. Una
delle questioni che occorre assolutamente affrontare è quella dell'esclusione. Mi sembra
che i modelli di comunicazione che vengono attualmente realizzati siano modelli che
favoriscono la segregazione e che del resto corrispondono a una nuova teoria dello
sviluppo del pianeta. Prova ne è che negli ultimi quindici anni abbiamo visto comparire
nozioni che in precedenza non esistevano, come ad esempio quella della triade, formata dai
Paesi europei, dall'America del Nord e dall'Asia Orientale, come polo di sviluppo del
nuovo ordine mondiale. Io credo che i modelli di comunicazione propri delle nuove
tecnologie dell'informazione siano contrassegnati da quel che potremmo definire un
arcipelago tecnologico, o meglio una sorta di tecno-apartheid. Effettivamente lo sviluppo
tecnologico si concentra inizialmente all'interno di nuclei, di regioni che rappresentano
veri e propri nodi in cui si concentrano tecnologie e capitali, tanto nel Nord quanto nel
Sud. Da questo punto di vista c'è minore distanza fra Milano e San Paolo che non fra San
Paolo e Recife. Questo è un fatto molto interessante, di cui tengono conto gli stessi
pubblicitari quando approntano le loro strategie identificando profili socio-culturali al
di là di ogni frontiera, e stabilendo, ad esempio, che un abitante di Malaga non è più
vicino al settimo distretto di Parigi di un abitante della periferia di New York. Si va
affermando un pensiero della segregazione, che a differenza di quanto avveniva nel XIX
secolo e in tutti i decenni precedenti, rompe con la cosiddetta ideologia della lotta, il
cui obiettivo era la giustizia sociale. Al giorno d'oggi è come se il contesto portasse a
pensare che il modello attuale non è in grado di integrare la maggioranza. Da questo
dipende anche la creazione di barriere non solo tecnologiche ma architettoniche. Mentre in
Europa il fenomeno è forse meno evidente che altrove; in Brasile o in Messico, se andiamo
in paesi come il Brasile o il Messico e osserviamo come sono costruiti i centri
commerciali, gli shopping center, noteremo che si tratta di vere e proprie fortezze o di
veri e propri ghetti riservati a coloro che possono consumare e che davvero fanno parte di
una classe globale. Perciò, come stupirsi del fatto che le tecnologie seguano questi
modelli? Le tecnologie in effetti si adattano a modelli sociali che esse non hanno modo di
esaminare. I modelli di impianto della tecnologia corrispondono alle logiche sociali e il
grande problema di oggi per quanto concerne le tecno-utopie è che vogliono convincerci
che attraverso la tecnica possiamo rimediare agli squilibri sociali ed economici. Tutti i
discorsi che si fanno intorno all'uso delle nuove tecnologie convergono in questa
direzione. Albert Gore, ad esempio, quando inaugurò le autostrade dell'informazione a
Buenos Aires agli inizi del 1994, disse: "Le autostrade dell'informazione renderanno
possibile l'agorà mondiale, la conversazione universale, e permetteranno di risolvere i
problemi legati a ineguaglianze sociali ed economiche." A mio parere si tratta di
un'utopia, di una tecno-utopia che va senz'altro denunciata come tale poiché è
precisamente un'ideologia che vuole farci credere che le tecniche siano portatrici di
modelli di trasformazione e non che siano a loro volta integrate all'interno di un
processo di trasformazione e che ne siano parte. E allora cosa fare a questo riguardo? Io
penso che qualunque tecnica, prima di essere tecnica, sia anzitutto una costruzione
sociale. Voglio dire che non è possibile concepire l'impianto della tecnica senza
soggetti sociali. Il ruolo dello Stato, delle società civili con i loro molteplici
settori organizzati, è proprio questo. E' per questo che la questione della tecnica è
tanto importante per la ridefinizione della democrazia. A condizione ovviamente che la si
metta in relazione con i soggetti sociali.

Domanda 9
Lei ha affermato anche che all'interno della globalizzazione si viene a creare un fenomeno
di personalizzazione o singolarizzazione dei media.
Risposta
Questo argomento ci consente di ponderare in maniera approfondita la nozione di
globalizzazione. Questa nozione ha una determinata connotazione che indica che, in
definitiva, "il mondo è un villaggio", come affermava Mac Luhan. L'errore di
Mac Luhan sta nell'aver ritenuto che il mondo sia realmente un villaggio, dimenticando che
se è vero che esistono sempre più sistemi logici i quali fanno sì che le innovazioni e
i programmi siano condivisi in tutto il mondo, c'è però anche una crescente
differenziazione nella ricezione di questi messaggi. Oltre al fatto che un numero sempre
maggiore di culture vogliono anch'esse "emettere" i loro messaggi e la loro
produzione culturale. Pertanto la ri-personalizzazione fa da pendant alla globalizzazione.
S tratta in effetti una reazione contro la globalizzazione e, come ho scritto in un libro
intitolato La comunicazione mondo, è la rivincita delle culture particolari, nel senso
che in sostanza c'è un processo di appropriazione di simboli globali, i quali vengono
infine rielaborati dalle culture locali. Oppure altrimenti vengono accettati tali e quali,
e allora è la capitolazione, la rinuncia di certe culture alla loro identità.

Domanda 10
Lei ha anche parlato di comunicazione come di una dimensione che crea un legame e che
unifica la società.
Risposta
Questa è la grande idea che ci deriva dall'Illuminismo: lo scambio culturale come
possibilità di unire un determinato territorio. Tutto è cominciato con l'idea di
nazione, che Gore usa ancor oggi, ma che rientra in tutti i discorsi sulla tecnologia e
sulle tecno-utopie della comunicazione fin dall'inizio. E' il concetto della grande
famiglia umana, in sostanza un concetto teologico, persino evangelico, e costituisce il
nucleo dell'idea di comunicazione, nel senso che la comunicazione deve "unire"
le persone, ed è perciò segnata da un elemento essenziale, sul quale non si insiste mai
abbastanza: l'ideologia della comunicazione è un'ideologia di pace, la comunicazione è
nata contro la guerra, contro l'idea di guerra, e mira a unire i popoli laddove la guerra
li separa. È per questo che la guerra, in fondo, è altrettanto importante. In quanto è
un elemento di contrapposizione alla comunicazione intesa come creatrice di legami
sociali. Si potrebbe dire che la comunicazione, nel senso in cui l'abbiamo definita, ossia
di restauratrice dei legami sociali, rimandi in qualche modo alla vecchia idea di
ricostituzione di una società pre-babelica, anteriore alla Torre di Babele. Questo
elemento accompagna puntualmente tutte le mitologie della comunicazione dall'Illuminismo e
dal Rinascimento in poi.

Domanda 11
Ritiene che ci siano stati cambiamenti nelle comunicazioni, ad esempio in rapporto a
quanto sta succedendo con la guerra nell'ex Jugoslavia, nel momento in cui elementi
dissidenti possono parlare al mondo attraverso Internet?
Risposta
Credo che effettivamente Internet dia la possibilità a informazioni che non sono
disponibili sul mercato di uscire, per esempio, dalla Serbia, e ad altre di entrare.
Tuttavia, vista l'attuale situazione della censura in Serbia, si tratta di un fenomeno
molto limitato. Rimane il problema di come far circolare queste informazioni. Qui torniamo
alle osservazioni fatte in precedenza: se non tutti hanno accesso a Internet e se non si
dispone di un supporto come la radio o i giornali, le notizie non possono circolare.
Nell'ex Jugoslavia le radio e i giornali sono stati chiusi o sostituiti, o si è cambiato
il direttore e questo evidentemente ha ridotto l'impatto di Internet, soprattutto
all'interno della Serbia.

Domanda 12
Un altro tema interessante è quello del controllo dei dati e del rispetto della privacy
in relazione alle nuove tecnologie. Praticamente tutte le nostre azioni possono essere
controllate, non è così?
Risposta
Questo scenario è vero e fa ugualmente parte del contesto tecno-utopico. Quest'ultimo,
infatti, non è contraddistinto soltanto dalla nozione di una globalizzazione finalizzata
alla pace, ma anche dall'idea di società globale o dell'informazione interconnessa.
Queste definizioni in realtà non ci aiutano a definire un bel nulla. La globalizzazione
è quel che io chiamo una nozione dal ventre molle, cioè è elastica nei suoi fondamenti.
Perciò credo sia necessario tornare, per caratterizzare la società attuale, a concetti
più seri, che riflettano un pensiero sociologico. Mi sembra che la definizione di
società del controllo, impiegata per la prima volta da William Burroughs, sia molto più
adeguata. Del resto è vero che ci troviamo dentro a società evolutesi dopo quelle che
Foucault chiamava "società della disciplina". Siamo dentro a società del
controllo a rapida rotazione, dove il modello è fondamentalmente quello della
razionalità imprenditoriale e manageriale. Credo che in effetti in questo processo sia
evidente come i collegamenti diventino sempre di più modalità di sorveglianza. E'
interessante notare che in generale questa domanda mi viene posta di rado. Quando si parla
di media e di sistemi di telecomunicazione si fa riferimento a regole generali, a Internet
e ai suoi addentellati, ma c'è un altro tipo di regolamentazione, di cui si è discusso a
lungo a Bruxelles, e che riguarda appunto la questione della privacy. Ne è uscita una
direttiva, in vigore già dall'ottobre del '98, concernente la protezione dei dati
personali individuali. Questo è un fatto importante perché riguarda l'intero processo di
creazione di banche dati aventi per oggetto gli individui. Eppure questa direttiva, che è
passata inosservata ai cittadini, è invece fondamentale, in quanto se non si regolamenta
la raccolta delle informazioni sugli individui, si arriverà a un insieme di connessioni
tali da farci finire tutti su un gran numero di schede che riportano il nostro profilo, le
nostre tendenze, eccetera. Ritengo che sotto questo punto di vista l'Europa sia
all'avanguardia. Non so quale sarà il grado di affidabilità di direttive come questa, ma
credo che si tratti di una riflessione importante. Se è vero che la società
dell'informazione libera l'informazione stessa, è anche vero che libera l'uso dei dati ai
fini del controllo e della sorveglianza. Senza arrivare al mondo di Orwell, questa è già
una realtà, semplicemente perché il mercato ha bisogno, in definitiva, di ritagliarsi
sempre di più un suo territorio particolare.

Domanda 13
Lei crede che la presenza di tanta informazione, che circola attraverso Internet e altri
media all'interno della cosiddetta società dell'informazione, possa creare un effetto
destabilizzante, un eccesso di informazione? Si stanno determinando nuovi equilibri?
Risposta
È una questione che appassiona moltissimo gli strateghi militari non solo del Pentagono
ma di tutti gli eserciti del mondo. E' interessante notare come nelle riviste militari,
nelle riviste pubblicate dalle accademie di guerra sia in Europa che negli Stati Uniti, si
sta gradualmente affermando il concetto di Netwar (guerra della rete) e di Cyberwar
(guerra cibernetica). In effetti si tendono a identificare nuovi nemici attraverso queste
tecniche di comunicazione, e può trattarsi anche delle reti informatiche. La cosa
interessante è che per loro i nemici sono anche le reti delle organizzazioni non
governative, le quali attuano una destabilizzazione per mezzo di iniziative contro accordi
come l'accordo multilaterale sugli investimenti, per esempio, oppure il Chiapas e gli
Zapatisti messicani, che rappresentano un altro esempio ricorrente nei rapporti del
Pentagono. Si tratta dunque di nuovi usi dell'informazione, i quali danno vita a un nuovo
concetto di guerra, la guerra informatica. Questo è un primo aspetto da considerare. Poi,
un altro punto a mio avviso importante quando si parla di nuove tecnologie e di nuovi
dispositivi di comunicazione, è vederne la faccia nascosta, la faccia segreta, che è
appunto quella della guerra. E' una questione fondamentale: in tutti i rapporti redatti
ufficialmente in Europa o negli Stati Uniti, noto sempre che gli esperti si arrestano là
dove entra in gioco il concetto di sicurezza nazionale. Sono convinto che una delle grandi
poste in gioco delle nuove tecniche di comunicazione riguardi appunto questa faccia
nascosta, e credo che in effetti, agli occhi dei nuovi strateghi e di quanti pensano le
nuove forme di guerra, l'informazione, la saturazione dell'informazione e la comparsa di
nuovi soggetti dell'informazione siano fattori di destabilizzazione. Tornando all'ambito
civile, è sempre più evidente che a meno di uno sforzo pedagogico gigantesco, se non
verrà abbandonata l'idea che sia la tecnologia a infondere una particolare attitudine a
trattare le informazioni, sarà difficile dominare un mondo tanto popolato di notizie. Il
problema sta appunto nell'individuare quale tipo di pedagogia occorra insegnare in
funzione dell'idea non più soltanto di consumatore, ma di cittadino, per tentare di
padroneggiare questa informazione a fini democratici. E a quanto mi sembra, non siamo che
all'inizio di questa riflessione.

|
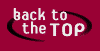 |